Immagini malgrado tutto
Analisi di Giuliana Iurlano
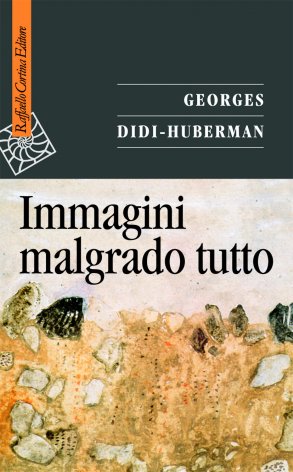
La copertina (Cortina ed.)
Recentemente mi è capitato di rileggere il volume di Georges Didi-Huberman (Immagini malgrado tutto, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2005) e, come la prima volta, è stato illuminante. Le “immagini malgrado tutto” sono quattro fotografie scattate (o, meglio, “rubate”) da un membro del Sonderkommando (un certo “Alex”, di cui non si conosce nulla, se non il nome) ad Auschwitz. Quei quattro fotogrammi sfuocati scardinano la stessa inimmaginabilità della Shoah, perché mostrano e, insieme, raccontano molte cose. Prima di tutto, la necessità di informare a tutti i costi il mondo di ciò che stava accadendo nei campi della morte, al di là del filo spinato, una necessità sentita prima di tutto dalle “squadre speciali”, create dalle SS nel luglio del 1942, incaricate di far sparire i corpi gasati e, a loro volta, destinate a morire, sostituite da altre. La loro stessa esistenza era soggetta al segreto assoluto: i membri del Sonderkommando, infatti, non potevano avere alcun contatto con gli altri detenuti e col mondo esterno, eppure alcuni di loro – di fronte a due “impossibilità”, la scomparsa prossima dei testimoni e la non rappresentabilità della testimonianza – scelgono la strada dell’immagine fotografica. Procurarsi un apparecchio fotografico, nasconderlo in un secchio, salire in cima al crematorio V e scattare, spesso alla cieca, delle fotografie, farle uscire dal campo nascoste in un tubetto di dentifricio non fu affatto una cosa semplice e quelle immagini raccontano la frenesia di far presto per “strappare al pensiero umano in generale [...] un ‘immaginabile’ per qualcosa di cui nessuno fino ad allora intravedeva la possibilità” (p. 20). Le prime due foto descrivono il “lavoro” quotidiano della squadra di Sonderkommando (spostare, tirare, trascinare, buttare i corpi), mentre sullo sfondo c’è il fumo nero delle fosse di incinerazione; il boschetto di betulle, scosso dal vento torrido e tropicale dell’estate del ’44 (testimoniato anche da Primo Levi ne I sommersi e il salvati). Le altre due foto, scattate dopo che l’“ignoto fotografo” si arrischia ad uscire dal crematorio e raggiunge il boschetto di betulle, riprendono alla meno peggio un gruppo di donne svestite che si appresta ad entrare nelle camere a gas; la seconda di queste due foto sembra “astratta”: si scorgono a malapena le cime delle betulle e l’immagine è rovinata dalla luce abbagliante del sole che filtra attraverso i rami.
La storia successiva di queste foto evidenzia i due modi in cui avviene quello che Didi-Huberman definisce come “processo di disattenzione”: da una parte, il tentativo di rendere ipertrofiche quelle foto, vale a dire, realizzare dei ritocchi per ingrandire alcuni particolari, ortogonalizzare le immagini, ritagliare e ridurre a scarto ciò che “non serve” e, soprattutto, inventare i volti attraverso un’aberrante sofisticazione; dall’altra, ridurre e asciugare l’immagine, così da potervi vedere soltanto un documento dell’orrore, rendendo le foto “più informative” di quanto non lo fossero originariamente. In entrambi i casi, le foto subirono una vera e propria manipolazione dal punto di vista formale, storico, etico ed antropologico. La “massa nera” della quarta foto che circonda la visione dei cadaveri e delle fosse e in cui nulla è visibile è, in realtà, un prezioso segno visivo: esso, infatti, è lo spazio della camera a gas, quella “camera oscura” in cui è stato necessario nascondersi per fotografare il lavoro dei Sonderkommando, restituendo la situazione precaria, lo spazio di possibilità della foto. Essa ci informa delle difficoltà stesse della vita e della morte nel campo di Auschwitz, delle difficoltà dell’enunciazione delle parole dei testimoni, fatta di interruzioni, silenzi, toni affaticati. La quarta foto, quella “astratta”, non è inutile dal punto di vista storico, perché testimonia l’impossibilità del fotografo di inquadrare, il rischio enorme da lui corso, l’urgenza, forse la corsa, la goffaggine, l’accecamento di fronte al sole, il fiato corto. È, insomma, “un’immagine senza respiro”, un “puro gesto”, un puro atto fotografico senza orientamento, che ci mette di fronte alla condizione di urgenza nella quale le foto vennero scattate. Insomma, questi quattro tragici fotogrammi parlano di Auschwitz in modo inequivocabile e forte, rendendo immaginabile ciò che si voleva restasse inimmaginabile per sempre.

Giuliana Iurlano è Professore aggregato di Storia delle Relazioni Internazionali presso l'Università del Salento. Collabora a Informazione Corretta

