Riportiamo dal CORRIERE della SERA di oggi, 10/08/2013, a pag. 46, l'intervista di Alessandra Farkas ad André Aciman dal titolo "Aciman: la mia vita è un lungo esilio e la letteratura finisce con Dostoevskij".


Alessandra Farkas André Aciman
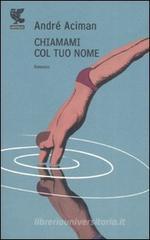

NEW YORK — «Harvard Square è un libro autobiografico. La mobilia è sempre quella di casa mia, anche se per prudenza e pudore ne ho cambiato la disposizione». Parla André Aciman, sessantaduenne autore d'origine egiziana, noto in Italia per bestseller editi da Guanda quali Chiamami col tuo nome — storia d'amore sullo sfondo della riviera ligure tra Elio, diciassettenne italiano, e Oliver, ventiquattrenne americano — e Ultima notte ad Alessandria, memoir sulla toccante fuga della famiglia dello scrittore dall'Egitto all'inizio degli anni Sessanta.
Nel nuovo libro, definito dal «New York Times» «il miglior romanzo finora scritto dall'autore» e dal «Wall Street Journal» «un racconto brillante dal sapore proustiano» — uscirà in Italia il prossimo anno —, Aciman ripercorre i suoi anni a Harvard, dove ha conseguito il dottorato in Letteratura comparata nel 1988. Al centro dell'opera, l'amicizia tra il protagonista, un giovane ebreo sefardita esule da Alessandria, e Kalaj, tassista arabo di origine tunisina, vulcanico, rozzo ma anche generoso e carismatico dongiovanni. Ad accomunarli è un fortissimo senso di alienazione e di sradicamento.
«Il sentirsi estraneo in ogni luogo e infelice nella propria pelle è un aspetto che permea intrinsecamente la mia scrittura», spiega Aciman. «Non conosco altra maniera di scrivere se non quella di immaginare che in un determinato momento del racconto i miei personaggi saranno costretti a subire qualche sorta di esilio o di alienazione. Proprio come è capitato a me e sta adesso accadendo ai miei tre figli».
Che cosa intende dire?
«Anche se del tutto americani, i miei ragazzi hanno ereditato da me un profondo senso di sradicamento e distacco che li porta a considerare New York come patria temporanea, luogo in cui risiedere, ma al quale non potranno mai appartenere fino in fondo. Un po' com'è accaduto ai figli e ai nipoti dei sopravvissuti all'Olocausto. Del resto ciò che caratterizza l'animo di noi ebrei erranti è proprio questo costante senso di disagio. Nell'attimo in cui ci sentiamo felici in un luogo o con noi stessi, smettiamo di essere ebrei».
Lei però ha anche radici italiane.
«I miei antenati si chiamavano Pardo-Roques. Vivevano in Toscana e sono stati tutti sterminati dai nazisti. Quando avevo 14 anni, con mia madre e mio fratello ci trasferimmo a Roma mentre mio padre si recò in Francia per lavoro. Dopo poco tempo i miei genitori si separarono ed io, ogni mese, mi assentavo dalla scuola americana che frequentavo in Italia per andare a trovare papà, anche perché per me la Francia era un idolo: la patria cui sentivo di appartenere. Non è poi stato così, anzi ne sono stato tradito».
In che senso?
«A 17 anni, dopo il liceo, mi trasferii a Parigi e una sera, lungo la via dell'Opéra, chiesi indicazioni a un signore che rispose domandandomi se fossi spagnolo per via del mio accento. All'epoca gli spagnoli erano la servitù e, dalla domanda in tono superbo, capii che per i francesi non sarei mai stato uno di loro. Al contrario dell'America, dove fin dal primo giorno mi sono sentito benvenuto».
Anche a Harvard?
«Sì, anche se il campus oggi è diverso da quello dei miei tempi. Come in tutte le università Ivy League, vi sono molti più asiatici ed ebrei, ma, nonostante ciò, questi piccoli regni continuano a difendere strenuamente la loro cultura wasp per paura di diventare come la Columbia di New York. Princeton, dove ho insegnato per 7 anni, ha la reputazione di essere totalmente anglosassone, anche se i docenti sono quasi tutti ebrei che, in virtù della cultura wasp dominante, sono riluttanti a rivelare la propria identità. Tutti sanno che il padre dell'ex presidente dell'università è il proprietario di una nota Delicatessen, ma nessuno ne parla».
In «Harvard Square» il forte erotismo dei personaggi è in chiave eterosessuale. Quando uscì «Chiamami col tuo nome» molti si chiesero se si trattasse di una storia autobiografica.
«Mi crederebbe se le dicessi che il più grande amore della mia vita è stato un uomo? Avevo 10 anni e lui 17. Eravamo amici in Egitto e lui non ha mai sospettato nulla, anche perché io stesso ero confuso, non capivo bene cosa stessi provando. Mio padre probabilmente non avrebbe approvato. Non è stato facile calarmi, cinquant'anni dopo, da uomo adulto, nei panni di quel ragazzino ipersensibile e trasferirne sulla carta le emozioni. Sembra però che alla fine vi sia riuscito. Secondo i lettori è il mio libro che li ha maggiormente colpiti».
Per quale motivo?
«Per la figura centrale del padre che esorta suo figlio a seguire il cuore, a non rinunciare a un amore che lui stesso rimpiange di non aver mai provato. Quel suo spirito comprensivo e sensibile alla base della narrazione ha toccato molti lettori, soprattutto over 50, che ancora scrivono per dirmi "mio padre non sarebbe mai stato capace di tanto". La mia ispirazione sono stati il padre di Giorgio Bassani ne Il giardino dei Finzi-Contini e quello di Carlo Cassola in tante sue opere: una figura paterna che rassicura il figlio, ricordandogli che la sofferenza è solo temporanea e finirà presto».
Quali altri scrittori l'hanno influenzata?
«A parte Marcel Proust e Jane Austen, l'autore che ha plasmato la mia scrittura è Dostoevskij. Adoro la sua capacità di penetrare l'animo umano fin dal primo sguardo, come avviene ne L'idiota, dove i personaggi si analizzano costantemente a vicenda. Henry James, che pure amo, non è mai stato capace di arrivare a tanto. Il mio scrittore preferito è però Tucidide. La Guerra del Peloponneso è il libro che prediligo in assoluto, perché al centro dell'opera non vi è soltanto una tragedia storica, ma anche le sue motivazioni umane. Non mi piace invece Tolstoj, perché penso sia superficiale».
Che cosa pensa degli scrittori contemporanei?
«La vera letteratura si è fermata a Max Sebald e al suo Austerlitz, il libro più autorevole degli ultimi 40 anni. Il resto — la generazione dei Safran Foer, Jonathan Franzen, Toni Morrison, Jonathan Lethem, persino Orhan Pamuk — non è degno di menzione, incluso Philip Roth, con le sue opere futili e dal linguaggio poco ricercato. In questo mi sento in perfetta sintonia col brillante ed esigentissimo Harold Bloom: anch'io non tollero l'idiozia e m'interesso soltanto all'eccellenza».
Perché un giudizio così severo?
«Oggi non esistono più scrittori, soltanto prosatori incapaci di raggiungere, come si faceva un tempo, il livello aulico della poesia. Le opere contemporanee non insegnano più nulla ai lettori. Sembrano tutte reportage di cronaca, oppure sceneggiature di film. Neppure i cosiddetti grandi si salvano. Penso a Ernest Hemingway: un pessimo scrittore che ha rovinato intere generazioni di giovani autori, convinti che il suo stile fosse da imitare».
Quali autori allora consiglia ai suoi studenti della City University di New York?
«Stendhal, Dostoevskij e Flaubert: maestri delle lettere che, a differenza dei contemporanei, erano tutti eruditi. Oppure i due grandi della letteratura italiana del XX secolo: Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Italo Svevo. Il Gattopardo è un capolavoro, anche se all'inizio fu bocciato da Elio Vittorini, un altro scrittore che amo molto. I primi romanzi di Svevo non sono in realtà molto interessanti, a parte Una Vita e Senilità. La coscienza di Zeno è un bellissimo libro, ma più francese che italiano. E poi Cesare Pavese: preferisco La bella estate a La luna e i falò. Anche Gli indifferenti di Alberto Moravia è uno splendido romanzo, ma lui come scrittore non è abbastanza complesso».
Ha speranza per il futuro della letteratura americana?
«Per nulla. Le facoltà letterarie non stanno facendo un buon lavoro con le nuove generazioni. Considerano la letteratura come un'attività commerciale e si preoccupano di insegnare ai giovani soltanto come comporre racconti brevi. Un genere ormai universale che consente d'essere pubblicati sul «New Yorker», ma non farà mai emergere l'unicità, problematicità e grandezza di uno scrittore».
Che cosa intende dire?
«Sull'influente settimanale dell'ex reporter David Remnick non vi è spazio per opere letterarie articolate e innovative. Se Dante, Proust, Joyce o James oggi, da sconosciuti scrittori, volessero pubblicare un racconto sul «New Yorker», non ci riuscirebbero. Al contrario di Thomas Mann, perché i suoi lavori sarebbero più accessibili ai pendolari durante i loro viaggi giornalieri in metropolitana».
Per inviare la propria opinione al Corriere della Sera, cliccare sull'e-mail sottostante

